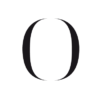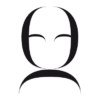Il corpo e il riparo: diritto all’acqua e arte contemporanea. Conversazione con Gian Maria Tosatti
Ci immergiamo nell’estetica dell’acqua e nella sua potenza simbolica attraverso l’incontro con Gian Maria Tosatti – a cui, nel 2022, l’Italia ha affidato le sue più grandi istituzioni artistiche, la Biennale di Venezia e la Quadriennale di Roma – scegliendolo come luminoso faro per indagare il riparo che la sua arte ha offerto all’acqua come diritto universale, e alla cultura come fluidità interdisciplinare.
di Fabiola Triolo
L’arte contemporanea è il regno del simbolo, e sovrana del simbolo è la metafora. È sul solco di una metafora che Ossigeno è oggi grato a Gian Maria Tosatti (Roma, 1980, vive e lavora a Napoli) per avere accolto l’invito a camminare tra queste pagine sulla traccia di un terreno fertile: quella della metafora tra arte e acqua.
Arte vivifica, come l’acqua.
Plastica come l’acqua.
Potente come l’acqua.
Diritto alla libertà dell’arte, come libera è – o dovrebbe essere – l’acqua. È in nome della potenza simbolica e prismatica dell’acqua che i più grandi artisti contemporanei hanno irrorato e sommerso le proprie opere, ma l’avere scelto Gian Maria Tosatti – cui, nel 2022, l’Italia ha affidato entrambe le sue più grandi istituzioni artistiche, la Biennale di Venezia e la quadriennale di Roma – come faro, per indagare la protezione che l’arte contemporanea mette in atto rispetto al diritto universale all’acqua, trascende la forma e coinvolge l’essenza: al di là del significativo impiego, poetico e simbolico, dell’elemento acquatico nella sua arte, Gian Maria Tosatti è un corpo d’acqua.
Mi spiego. H2O, due parti di idrogeno e una di ossigeno, per dare vita al composto che per antonomasia dà la vita. Diplomatosi in Regia, laureatosi in Lettere Moderne, artista, saggista, critico ed editorialista culturale, la sua struttura, come quella dell’acqua, è composita.
Ma non solo. Tratta dal sito di un tempio internazionale dell’arte contemporanea quale è il Pirelli HangarBicocca: «La pratica dell’artista italiano Gian Maria Tosatti è incentrata sui concetti di identità, collettività e memoria, nella loro valenza storica, politica e spirituale. Svolgendo lunghe e articolate ricerche, e attingendo liberamente al linguaggio delle arti visive, della performance e dell’architettura, Tosatti realizza grandi installazioni site-specific, spesso concepite per interi edifici o aree urbane e destinate a durare per lunghi periodi di tempo. Il suo lavoro coinvolge inoltre le comunità connesse ai luoghi in cui le opere, spesso contraddistinte da una forte ciclicità, prendono corpo». Ciclicità. Attingimento. Permeabilità. Collettività. Fluidità. Durata. Anche la sua biografia ufficiale possiede i caratteri dell’acqua.
E ancora: l’immaginario è la fonte primaria da cui l’artista attinge per dare corpo alla propria visione, e in un suo editoriale del 2009 per quell’inciampo luminoso che è stato La Differenza – pubblicazione culturale di cui è stato genitore, prima che direttore – Tosatti scrive: «L’immaginario è un mondo molle, di mercurio, attraversabile, rapido, sfuggente, liquido, fatto di desideri e paure. Eppure talvolta entrare nel mondo dell’immaginario, attraversarlo, diventa un passaggio obbligato per proseguire in una certa direzione, per poter veramente andare oltre. L’immaginario diventa il fiume che si deve superare a nuoto».
Con la consapevolezza del valore prezioso dell’acqua, e con la volontà dello scardinamento di luoghi comuni pregiudicanti, posso dire che tanto l’opera quanto l’immaginario di Gian Maria Tosatti fanno acqua: generano e nutrono. E da calabrese che vive sul mare, in una Calabria che sa di quella Napoli che Tosatti ha scelto come casa, sono altrettanto consapevole che un corpo d’acqua ha bisogno di acqua.
È ciò che mi conferma lui stesso: «Nel 2013 ho iniziato un progetto a Napoli che si chiamava Sette Stagioni dello Spirito. Tre anni di lavoro di grande intensità. Mi spostai lì da New York, la città in cui vivevo. Peppe Morra, grande mecenate, mi mise a disposizione una casa che aveva due stanze. Una era lo studio in cui avrei dovuto lavorare. Aveva finestre piccole, posizionate molto in alto, quasi non si riusciva a veder fuori. Si vedeva solo il cielo. L’altra stanza era la camera da letto, con sei grandi finestre, da cielo a terra. Affacciavano tutte sul golfo di Napoli. In basso la città. Di fronte il mare. A tutto campo. Senza niente che me lo coprisse. Di notte, la luce del faro mi veniva a cercare negli angoli. Finito il progetto, nel 2016 me ne tornai stabilmente a New York, ma due anni dopo decisi di ritornare a vivere a Napoli, di stabilire lì il mio studio. E decisi che lo avrei fatto solo se avessi trovato un’altra casa dalle cui finestre si vedesse il mare. Così fu».
C’è ancora un motivo per cui Gian Maria Tosatti può farsi testimone del rapporto tra arte contemporanea e acqua, e risiede in quella similarità tra il suo modo di lavorare e quello che Leonardo chiamò sangue della Terra, tra mare, cielo e suolo, tra evaporazione, condensazione, precipitazione e infiltrazione: è il ciclo dell’acqua, ed è semplicemente vitale.
Una delle costanti dell’opera di Tosatti è proprio quella di lavorare per cicli. Romanzi visivi, sono stati spesso definiti, capitoli consequenziali che compongono un unico, potente ritratto. Sulla doppia natura umana, trascendente e terrena, in Devozioni (2005-2011). Sul rapporto con lo spazio, in Landscapes (2006-2011), e con la memoria, in Le considerazioni sugli intenti della mia prima comunione restano lettera morta (2009-2014). Sulla solitudine aliena che sfocia dalle promesse mancate di New York, città in cui ha vissuto per dieci anni, in I’ve already been here (2011-2014).
Sul cammino di redenzione la cui ispirazione è Il castello interiore (1577) di Santa Teresa d’Avila – che suddivise l’animo umano in sette stanze, e che Tosatti ha reso toccanti luoghi dell’anima recuperando e rigenerando sette edifici storici e abbandonati di Napoli, quasi come fossero gli esercizi spirituali di quei capolavori di Leonardo Sciascia in letteratura (1974) e di Elio Petri in cinematografia (1976) per Todo Modo – nelle Sette Stagioni dello Spirito (2013-2016).
Sul naufragio dell’Europa nella Jungle di Calais in Histoire et Destin (2015-2016), e dell’idea stessa di democrazia già cristallizzata a Catania, a Riga, a Cape Town, a Odessa, a Istanbul, pronta a salpare per nuovi porti, in Il mio cuore è vuoto come uno specchio (2018-2025).
La stessa Storia della Notte e Destino delle Comete attraverso cui il Padiglione Italia, alla 59. Biennale Arte di Venezia, si è presentato al resto del mondo affidandosi per la prima volta a lui come unico cantore, era in due atti.
Panta rei, tutto scorre, è una massima che racchiude la storia e un atteggiamento, ed è quella di Tosatti una storia artistica che leggerei come un unico, potente ciclo all’interno del quale, come per il ciclo dell’acqua, è la stessa presenza dell’essere umano a evaporare, dalla performance alla più pura installazione ambientale. Come per l’acqua, tuttavia, quella dell’essere umano non è un’assenza, ma piuttosto una sublimazione in ciò che Tosatti ha spesso definito la saggezza dei vinti: attraversando i sud del mondo, là dove è più forte la sete, «I temporaneamente vinti rispondono al conflitto con reazioni alternative, non cercando una revanche, ma inventando un’altra strada per migliorare la storia», ha scritto.
Come per l’arte di arrangiarsi, fatta anche di pasta mista, messa insieme coi resti degli altri pacchi di pasta, e di spaghetti alle vongole fujute. Come per La pelle (1949) di Curzio Malaparte, dove i veri vincitori sono quelli che portano con dignità, creatività e poesia il peso della loro sconfitta. Come per la legge del mare, non codificata e forse proprio per questo la più umana delle leggi, che ti impone di salvare una vita non per obbligo giuridico, ma morale. Chi tene ‘o mare cammina c’a vocca salata, cantava Pino Daniele, tra l’illusione del tutto e il riscontro del niente; ma, fratello complice, «Il mare non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare», scrisse Giovanni Verga, autore del ciclo dei vinti. E tornando al contemporaneo, Tutto brucia è il titolo di una delle più recenti produzioni teatrali dei Motus, libero adattamento da Le Troiane di Euripide, che racconta di una civiltà vinta e svenduta. Non la fine del mondo, ma la fine di un mondo, di un paradigma esausto.
Quando tutto brucia, l’acqua salva e rigenera. E quando tutto brucia, l’arte è catartica. «Il compito dell’arte è quello di farci sentire nelle vene il bruciore di una condizione insostenibile, che chiede il nostro cambiamento. La tragedia è per me l’atto fondatore dell’arte moderna, atto fondatore che si basa sul meccanismo della catarsi, e la catarsi non è la morale. La catarsi è uscire dalla tragedia veramente con il sangue che ti brucia nelle vene e ti dice che non puoi continuare a essere ciò che sei stato fino a oggi, perché devi cambiare», sono state le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione del Padiglione Italia, nel febbraio del 2022.
Acqua salvifica, arte catartica. Ma, come l’acqua, occorre che l’arte sia indipendente, che entrambe non debbano mai essere rese merce di scambio. Acqua libera, arte libera. Sono i luoghi in sofferenza che diventano dunque le sue ambientazioni predilette, mai calcando una mano supponentemente compiaciuta sul marcimento, sulla gentrificazione incontrollata, sull’abbandono, ma piuttosto immaginando una vita nuova, totalmente altra, una rigenerazione, perché è dove c’è una ferita aperta che l’arte, come l’acqua sterile, può curare. L’acqua, la insegna la sete è il primo verso di una poesia del 1859 di Emily Dickinson.
Gli chiedo dunque, nell’arte e nella cultura, cosa lo asseta e cosa, invece, lo disseti: «Aver sete, talvolta, è pregustare l’acqua che ci disseterà. Quadriennale per me è stato questo. Rimettere a posto, pezzo a pezzo, tutti i problemi irrisolti che hanno compromesso la formazione della mia generazione artistica. Senza clamore, senza pretese, senza voler convincere nessuno. Abbiamo ristabilito l’equilibrio in silenzio, lavorando. E questa incontestabilità di un fatto significativo nella storia di una generazione artistica era il senso di soddisfazione che già pregustavo quando, assieme ai miei compagni di strada, eravamo disidratati fin quasi al collasso».
Certo, ci vogliono spalle larghe per sostenere, come un Atlante contemporaneo, non solo i duemila metri quadri del Padiglione, ma anche la direzione artistica della Quadriennale di Roma, somma istituzione nazionale che studia, promuove e incornicia di quadriennio in quadriennio lo stato dell’arte contemporanea in Italia, per la quale Tosatti ha ricevuto la nomina quasi in simultanea con la chiamata per la Biennale. Incarichi come carichi ciclopici, ma la lezione può venirci, ancora una volta, dall’acqua, H2 O, due parti di idrogeno e una di ossigeno.
Tosatti rispose alla doppia chiamata della Biennale e della Quadriennale – una chiamata alle armi alle arti, fedele a Brecht nel considerare l’arte come l’ultima linea di difesa dell’umanità – con uno statement che fu dissetante e sacrosanto: «Sono un artista, e se dirigo un’istituzione culturale sono nel posto in cui devo essere. Questo è uno di quei momenti in cui si pensa che un artista sia una figura che usa il pennello per creare graziose decorazioni. No, un artista è esattamente come Leonardo Da Vinci, come il Bernini, come Pasolini: uomini di vasta cultura con conoscenze trasversali; persone che, per poter fare una cosa, ne devono saper fare dieci».
Gli racconto che dove abito c’era un minimarket, parecchio in voga tra i nonni che ti ci spedivano almeno una volta al giorno, che si chiamava Non tutto ma di tutto, esempio di tutta l’accoglienza poetica che porta con sé il vernacolo (quel minimarket è diventato oggi una sala scommesse, il che la dice lunga, ma questa è un’altra storia). E mi riaggancio alla parabola luminosa di Adriano Olivetti, che nella sua azienda assumeva sempre a terne di professionalità – un economista, un tecnico e un umanista – per poter mantenere fertile il dialogo interdisciplinare, citando le parole di un altro suo editoriale, dove Tosatti scrisse della necessità di una riforma scolastica che potesse fare leva su educatori dalla cultura multiforme come innesco per una reale, armoniosa evoluzione, «perché non c’è verso che io possa spiegare l’estetica senza la meccanica quantistica».
H2O, due parti di idrogeno e una di ossigeno, per dare vita al composto che per antonomasia dà la vita. Posto che l’arte non potrà mai essere una formula, mi piacerebbe tuttavia sapere quali siano per Tosatti l’idrogeno e l’ossigeno, gli elementi sine qua non, che compongono la struttura altrettanto vivifica dell’artista, e mi rendo conto di quanto per lui, come per l’acqua, semplicemente non possano esistere separazioni stagnanti: «Credo che il problema, in questi ultimi decenni, sia stato proprio il voler dividere le molecole. Gli uomini tendono a pensare semplicemente. Come se 1+1 facesse semplicemente 2. E invece non è così. Il due non è la somma di 2 unità. È tutto un altro concetto. Un uomo e un altro uomo, quando sono insieme, non sono 2 singolarità. Sono compagni di viaggio (e quindi ecco che si aggiunge un elemento, il viaggio). Sono fratelli (ed ecco che si aggiunge un elemento, la famiglia, naturale o elettiva). Sono amanti (ed ecco che si aggiunge un elemento, l’amore). E potrei andare avanti a lungo… La storia dell’arte è fatta di quelle storie che da soli è molto difficile scrivere. Anche perché quel conto che non torna, quell’eccedenza che sta nel due rispetto alla semplice somma di 2 unità muove valenze come il viaggio, la famiglia, l’amore e tanti altri elementi che non abbiamo citato, e che potremmo all’infinito. Dice bene lei. Dall’unione di due gas piuttosto pericolosi per l’uomo, idrogeno e ossigeno, nasce l’elemento che consente la vita su questo pianeta. Quindi vede, non solo 1+1 non fa semplicemente 2, ma addirittura il due rovescia il valore dell’1+1. Così è per l’arte».
E continua: «È per questo che, quando ero un ragazzo, ho lottato con tutte le mie forze per non essere ricondotto alla normalità – o a quella che si presumeva lo fosse. Si figuri, io a ventidue anni ero responsabile della pagina degli spettacoli su un quotidiano, ero un critico di teatro e di danza, dirigevo un gruppo di ricerca che affrontava i principi fisici della performance e avevo appena pubblicato, come curatore, il mio primo libro di teoria. Ero uno scandalo. Me lo ricordo bene. O scegli o ti molliamo. Me lo diceva chiunque, anche quelli a cui non avevo chiesto niente. Per il gusto di ribadire che un artista è un artista, un critico è un critico, un teorico è un teorico… Che miseria! E che ignoranza! Non avevano la benché minima consapevolezza che la tradizione artistica italiana elencava figure che vanno da Leonardo (fisico, pittore, ingegnere), a Michelangelo (scrittore, pittore, scultore, architetto), a Bernini (pittore, scultore, architetto, regista di teatro), fino a Pasolini (giornalista, poeta, regista cinematografico, drammaturgo) e a Testori (giornalista, critico d’arte, poeta, drammaturgo, regista)».
«Effettivamente, poi, fu così: mi mollarono. Dicevano che non avevo le carte in regola per farcela. Me lo ricordo bene, suscitavo sfiducia. E così me ne andai a vivere altrove, in un paese che si faceva molti meno problemi di etichetta. Ci sono stato dieci anni. Quando sono tornato, molti di quelli che non avevano creduto in me non erano più in gioco. Forse avrebbero dovuto preoccuparsi un po’ più per se stessi. Oggi non devo più lottare per me. Però per gli altri sì. Ed è la ragione per cui ho assunto la responsabilità di dirigere la Quadriennale. L’obiettivo è quello di costruire le infrastrutture perché questo paese possa dare piena dignità ai suoi artisti, senza che debbano andare a rifugiarsi all’estero».
Una chiamata alle arti, dicevamo. Tosatti me lo ribadisce nel momento in cui faccio mia la sua lezione sulla necessità di fluidità – identitaria, professionale, interrelazionale, interdisciplinare – come urgenti viatici di salvezza, e passo dalla chimica dell’acqua alla fisica dei liquidi, per domandargli di arte. «Un corpo immerso in un liquido subisce una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del liquido spostato»: è la cosiddetta Spinta di Archimede, legge che spiega perché, immersi in acqua, non affondiamo. Nel mare magnum dell’arte contemporanea (o sedicente tale, quando crede che basti proclamarsi artivisti tagliandocisi una ciocchetta di capelli a favore di fotocamera e in nome dell’Iran martoriato – e chi sei, Sansone? – senza capire che, se è arte e tornando alla stagnazione delle etichette da lui appena citata, non ha bisogno di fantomatiche aggettivazioni da affibbiarsi perché ha già, per diritto di nascita, le mani impegnate a lavare via sangue e soprusi), gli chiedo dunque quale sia la personale Spinta di Archimede che lo sprona ad alzarsi, prendere il caffè e fare arte, non affogando mai nell’acqua torbida dell’artwashing. Tosatti mi risponde senza esitare: «Quella forza si chiama obbedienza. Ne parla anche Santa Teresa d’Avila. Ci sono chiamate altissime nella nostra vita. Possiamo decidere di obbedire, o far finta di non aver sentito».
Per quanti si limitino a navigare a pelo d’acqua questa potrebbe sembrare una risposta pretenziosa, quasi neocatecumenale. Ma Gian Maria Tosatti non è artista, né tantomeno uomo, che presta il fianco alla superficialità; Tosatti guarda dritto nell’abisso, immergendovisi, ed è da lì dove il soccorso è più necessario che disegna sempre una via d’uscita. In questi giorni in cui rileggo la nostra conversazione, assisto alla devastazione idrogeologica che ha colpito Ischia, e mentre stendo le parole del nostro incontro ripenso alle sue, di parole, scritte nel 2015 per il Corriere in occasione di un precedente, ennesimo dissesto causato da quella fragilità che abbiamo barattato con l’onnipotenza: «Ci diranno: “Il mondo sta crollando e voi disegnate fiori?”. Risponderemo: “Disegniamo fiori proprio perché il mondo sta crollando”».
Perché è questo, l’arte: strattonare le coscienze attraverso la potenza di un’icona. Perché 1+1 non dà 2, ma due. Perché tutti viviamo in riva allo stesso mare, ognuno chiamato all’obbedienza dell’assecondare, e possibilmente del condividere, il proprio dono. Perché nessuno possa ancora credere di potere, scelleratamente, salvarsi da solo. Perché, di fianco alla rivendicazione di un diritto, ogni essere umano non dovrebbe mai dimenticare il dovere della cura.
Pensando alla cura mi viene in mente il caffè napoletano, che si dice sia più buono. Al di là del fatto che io sono devotamente d’accordo, la motivazione più accreditata sembra essere una über alles: l’acqua, quella che sgorgava dalla fonte del Serino e che riempiva la rete idrica di Napoli. Certo che l’acqua, uno dei due soli ingredienti che compongono il caffè, è fondamentale; ma, come sempre, va maneggiata con cura.
A Napoli vive una storia antica che recita: «Se il saggio napoletano indica la tazzina di caffè che ha preparato, lo sciocco guarda il caffè»; invece dovrebbe guardare il dito, e poi risalire dal dito al braccio, e da questo al saggio napoletano che lo ha appena preparato, con sapienza, con cura.
A Napoli, il dito è ‘o rito. Ed è questo, a Napoli, il caffè: un rito antropologico, una liturgia sociale venerata quanto si venera San Gennaro, un acceleratore di accoglienza, un abbraccio caldo e fluido tutto limpido nel monologo di Eduardo de Filippo, orgoglioso di confidare al professore del balcone dirimpetto i suoi segreti nella cura della preparazione del caffè in Questi fantasmi! (1945).
Mi assumo tutte le responsabilità, in tempi in cui la schwa ə è d’obbligo per una certa intellighenzia, nel dire che Napoli è femmina. Che Lampedusa è femmina. Che Calais è stata femmina, e che Tosatti s tesso lo è, tutte le volte che mette in arte l’urgenza di accoglienza – lui stesso ha sottolineato, nella sua autobiografia, quanto sia stato importante, in termini di costruzione di un immaginario tutto felliniano, l’essere cresciuto con due genitori di sesso femminile, sua madre e sua zia (come la Carrà, mi permetto di dire per mia imperitura devozione). E sì, dico che anche l’acqua è femmina, facendomi forte di una teoria sociologica contemporanea, quella dell’idrofemminismo di Astrida Neimanis, che ha evidenziato una potente congruenza nella «intensa intimità tra il valore dell’acqua e la cura delle donne», nel comune donarsi per accogliere, nel farsi mare e madre (mer et mère, in Hélène Cixous e Catherine Clément, The Newly Born Woman, 1986). Sorgente dell’idrofemminismo è la gestazionalità, la capacità di generare e accogliere l’altro da sé resasi oggi ancor più necessaria nel rapporto con le ridotte risorse idriche, nel creare nuovi immaginari, fluidi e comprendenti, per «visualizzare, agire e vivere l’acqua» (Antonella De Vita, Corpi d’acqua. La svolta idrofemminista di Astrida Neimanis, 2021).
Fuori dall’alienazione delle logiche da catena di montaggio, imparando dall’acqua e dal femmineo la adattabilità, la relazionalità e la resistenza, scrive De Vita: «L’acqua è capace di mettere in connessione i corpi, farli fluire uno nell’altro, muoversi per inter-permeazione. L’acqua ibrida le soggettività, scavalca i confini dell’individualismo, dichiara, nel superamento del confine tra l’Io e l’Altro, la comunione e la solidarietà», rendendo il pensiero amniotico, il corpo interattivo, aperto alle confluenze, determinando l’importanza vitale della capacità di cura.
Quella cura accogliente che si mette a Napoli nella preparazione del caffè, e che Tosatti mette in arte, nel concepimento e nella preparazione delle sue installazioni ambientali. A ben pensarci, l’arte contemporanea (e le aste fallimentari…) sono ree di aver svuotato del significato originario una pratica poetica come quella della cura attraverso la creazione di una professionalità specifica, quella del curatore, che da donatore di accoglienza è divenuto una specie di semidio pagano dell’intellighenzia di cui sopra, la cui principale occupazione sembra essere quella di rendere l’arte ostica – il che, nella barriera verbosa che erige, è l’esatto contrario della pratica acquea, materna, propria della cura. Gli domando allora, per un’arte – la sua – in sé già materna, acquea e piena di cura, se abbia ancora senso la figura del curatore, e la sua risposta naviga sulla rotta di quell’1+1 che mi ha appena descritto: «Vede, il problema è nelle semplificazioni. Che cos’è un curatore? Un’etichetta. Né più né meno. Ma un’etichetta rischia di ridursi a un perimetro infinitesimale, rispetto alla pienezza del fenomeno. È come dire chi è un italiano. Chi è un bianco. Chi è un nero. Chi è un immigrato. Lo dissi una volta in una conferenza al Lincoln Center. Era un grande panel con molti esperti di immigrazione. Metà di loro, come me, erano stranieri che risiedevano in America. Però parlavano dei migranti usando la parola “they”. Io, che parlai per ultimo, dovetti farglielo notare. È da queste semplificazioni che nasce la nostra sconfitta come civiltà. E questo vale per le cose grandi come per quelle piccole. Curatori non ne conosco, e non mi interessa conoscerne. Conosco uomini e donne con cui ho voglia di lavorare perché le loro attitudini sanno dare un contribuito importante al viaggio che intendo fare. Talvolta il loro è un contributo di carattere critico, altre organizzativo, altre umano. Spesso un insieme di tutte q ueste cose. Ma il punto è che per me può aver senso avere accanto una persona come Eugenio Viola, come Alessandra Troncone o come Vicente Todolì. Penso alle persone, non al loro ruolo».
Anche questa somiglia molto alla lezione dell’acqua, fatta di legami saldi. Inoltre, vitale e potente, l’acqua muta forma assecondando il suo contenitore. Esattamente come l’arte. Immergiamoci, allora, nell’estetica dell’acqua.
Penso all’acqua come fluidità, nell’arte di Roni Horn.
All’acqua come purificazione, nell’arte di Bill Viola.
All’acqua come espiazione, nell’arte di Marina Abramović.
All’acqua come futuro, nell’arte di Ólafur Elíasson.
All’acqua come movimento, nell’arte di Pina Bausch.
All’acqua come trasformazione, nell’arte dei Masbedo.
All’acqua come abisso, nell’arte di Per Barclay.
All’acqua come potenza, nell’arte di Anish Kapoor.
All’acqua come lacrime, nell’arte di Francesco Vezzoli.
All’acqua come materia, nell’arte di Gino De Dominicis.
E penso a Gian Maria Tosatti, e all’acqua come diritto, tanto universale quanto bisognoso di riparo. Le sue opere sono spesso allagate, sono sommerse, sono fluide, sono assetate. Acqua fragile come cristalli di vetro in frantumi che inondano pavimenti. Acqua e fango da spalare che si confondono con la linea dell’orizzonte, nell’Episodio di Odessa del ciclo Il mio cuore è vuoto come uno specchio. «Sì – mi dice – l’acqua ricorre nel mio lavoro. Penso ai mille metri quadrati del secondo capannone del nostro Padiglione nazionale, completamente allagati. Ma penso anche a un elemento che stava quasi alla fine di una delle mie opere più angoscianti, 4_Ritorno a casa, nelle Sette Stagioni dello Spirito. Era un bicchiere pieno d’acqua, con accanto una bottiglietta di Novalgina. Poi penso ai rubinetti aperti della grande installazione a Casa Bossi (Tetralogia della polvere, 2012, NdR), come se quel precipizio tra il rubinetto e il fondo del lavandino potesse mostrare il sangue di questo enorme edificio ottocentesco, che fluiva dalle vene di piombo nelle pareti e vi ritornava. E poi c’è un’opera del 2009, La stanza bianca, dove il senso della morte era dato dal rumore dell’acqua che si sentiva nel locale docce di una fabbrica chiusa e completamente al buio. E, in ultimo, ricordo una delle opere che amo di più, Rassa, un registratore a bobine che riproduce il suono dell’alto mare».
«È un grande enigma, l’acqua», riflette Tosatti. «Baudelaire diceva che si guarda il mare per guardare se stessi. E forse si guarda dentro un bicchiere, come dentro uno specchio, per vedere una porzione soltanto della nostra figura, forse la parte che fa male e che dev’essere lenita, magari, con una medicina».
Il monito che custodisce, allora, la sua estetica dell’acqua c’entra molto con quella disperata vitalità evocata da Pasolini, e con il senso di rinascita: «Spesso l’acqua ha a che fare con la morte nel mio lavoro, ma anche con la vita. La morte dell’altro, a volte, ci fa rendere conto che noi siamo ancora vivi, che noi abbiamo ancora tempo».
Il tempo. Nelle sue installazioni sembra sospeso, cristallizzato. quasi impossibile dare loro una connotazione temporale, probabile accorgimento scenico che gli viene dal diploma conseguito in Regia – al Centro di Sperimentazione di Ricerca Teatrale a Pontedera, dove lavorava un gigante come Jerzy Grotowski – per rispondere a una sua precisa, espressa volontà: quella di rendere l’arte esperienza, estetica, estatica, mai anestetica, e il visitatore performer, immergendolo in un ambiente libero da qualsiasi ammiccamento temporale. «La sua ricerca costituisce un unicum nel panorama artistico italiano e contemporaneo, ed è profondamente influenzata dal peccato originale del teatro», nelle parole di Eugenio Viola.
Definendo i musei come reparti di terapia intensiva per le opere d’arte, e ammonendo a non confondere «il cimitero, con tutta la sua sacralità, con gli spazi della vita», Gian Maria Tosatti sanifica l’arte dalla pomposità naftalinica, prima causa di una certa puzza sotto il naso, e la lascia libera di scorrere per strada. «La pratica dell’artista credo sia quella di portare la battaglia, come un capitano di ventura, di città in città. E per farlo bisogna che il fatto avvenga in strada, tra la gente, come una guerra civile, una guerra di civiltà. Sarebbe ben strano combattere una guerra nel ritiro dei musei o delle gallerie», scriveva nel 2013. Portare l’arte negli spazi della vita fluidifica la separazione tra arte e vita semplicemente dissolvendola, sciogliendo quella barriera, finalmente elevando l’esperienza artistica a quella vitale.
Esperienza e realtà. Teoria e riflessioni sulla quinta dimensione (2022) è il titolo del suo ultimo saggio, all’interno del quale Tosatti scrive dell’arte ambientale come pratica consapevole della penta dimensionalità della realtà – fatta di lunghezza, larghezza, profondità, tempo e, appunto, esperienza, percezione fisica e cognitiva del visitatore – mettendo in scrittura ciò che nelle sue installazioni mette in arte.
Installazioni, le sue, cui accedere aprendo porte chiuse in mezzo a una strada, romanzi visivi prevalentemente privi di battage pubblicitario e comunicativo – se non quello, il più sincero, del passaparola – di fronte ai quali rispecchiarsi uno alla volta, in silenzio, perché per vivere l’arte non serve un’audioguida. E a quanti più o meno velatamente lo accusano di fare scenografia più che arte, lui più o meno fregandosene risponde attraverso l’arte stessa; perché se il vero performer è lo spettatore, il suo dovere di artista non può che essere quello di preparare per lui la più intensa delle scenografie.
Nel parlarne con Gian Maria, mi sembra limpido come l’acqua che l’aver reso la sua arte pubblicamente esperibile risponda prima di tutto a un atto di gratitudine. La sua educazione sentimentale cresce infatti per strada, in quella Roma che è un museo a cielo aperto, a ingresso libero e consumazione altrettanto libera, all’interno della quale, sulla strada per il campetto, un bambino inciampa in un Bernini, in un Borromini, oggi anche in un Kentridge, che vanno silenziosi a occupare le sedute cristalline dell’immaginario e che saranno pronti a riemergere, non appena a esso si attingerà. «Da ragazzino – mi racconta – andavo tutti i giorni a trovare mia nonna all’ospedale San Giacomo di Roma. Prendevamo l’autobus e scendevamo sul lungotevere. Da lì passavamo accanto all’Ara Pacis e al mausoleo di Augusto, poi per Via del Corso, passando davanti allo studio di Canova – che ora è di Ontani – e poi dentro l’ospedale, la cui architettura è stata forse la mia morfologia artistica di base. All’uscita attraversavo Piazza del Popolo, entravo quotidianamente nella chiesa in cui sono conservati due dei più noti Caravaggio e poi di nuovo in autobus, fino a casa. E in mezzo a questo percorso, tra alcune delle meraviglie di Roma, c’erano le sculturine di Fausto Delle Chiaie. Piccole, allusive, interagivano con quei monumenti imponenti. Li dissacravano o partivano per storie tutte loro. Io le seguivo lungo il percorso come si segue un sentiero fatto di molliche di pane. Ogni giorno, per venticinque anni, ha posizionato le sue piccole sculture attorno alla recinzione del mausoleo di Augusto, lungo la strada per l’ospedale. Erano sublimi. E io fantasticavo. Quelle piccole opere mi facevano viaggiare».
Un atto di gratitudine, il suo, verso l’arte pubblica che lo ha dissetato, che ha i tratti del contraccambio: la sua arte fluisce in mezzo alla strada, sgorga libera per chiunque abbia sete. A Roma, in L’Hôtel sur la Lune (2011), è un telescopio fatto di barili di petrolio dismessi, richiamo a Le Voyage dans la Lune di Georges Méliès (1902) come constatazione che non ci sono più occidenti da conquistare, posto in cima a un ex salumificio abbandonato, su richiesta della comunità in transito che lo abita – per segnalare la propria presenza a chi ne finge l’assenza, per saltare verso un altrove che porta le fattezze di una luna finalmente più vicina. A Napoli, in My dreams, they’ll never surrender (2014), è una distesa di centomila spighe di grano nutrita da un sole di latta e posta nel punto più remoto di Castel Sant’Elmo, un tempo utilizzato come prigione; centomila spighe di grano destinate a seccarsi, come lo è stato il pensiero di Gramsci incarcerato e poi disinnescato, a meno che lo stato italiano non decida di prendersene cura, prendendosi finalmente cura di se stesso.
A Calais, per il capitolo finale del ciclo Histoire et Destin – New Men’s Land (2016), è una stella precipitata dallo stendardo dell’Europa, una autentica rovina dorata in mezzo a rovine impolverate, mare alle spalle, in quel lembo di terra promessa e poi mancata che è stata la Jungle, prima vera città del ventunesimo secolo, concepita dai migranti e abortita dall’Europa.
A Scampia, in Elegia (2019), è un incanto di eterotopia nella quale inciampare all’interno della stazione metro, un paesaggio domestico dove la vernice delle pareti si scrosta in una miriade di petali di rosa, in omaggio all’umanità, alla grazia, alla gentilezza con cui i napoletani lo hanno incondizionatamente accolto.
Incondizionatamente, liberamente, come dovrebbe essere l’accesso all’arte. Incondizionatamente, liberamente, come dovrebbe essere l’accesso all’acqua, scandito nel sesto dei diciassette obiettivi che compongono l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
C’è un racconto di Raymond Carver – Cattedrale, del 1983 – in cui un uomo cieco domanda a un suo amico di fargli comprendere come sia fatta una cattedrale, e lui gliela disegna, calcando il tratto e permettendogli di sentire sotto i polpastrelli la pressione della matita, così da poterla immaginare. Ma a volte la realtà è ancora più potente e immaginifica della finzione: quando Antoni Gaudí progettò la cattedrale della Sagrada Familia si concentrò su una sola delle quattro facciate, intuendo che il tempo non gli sarebbe bastato ma senza mai smettere di pensare oltre i suoi stessi limiti. Gaudí immaginò una foresta di pietra, colonne come alberi, e ne portò avanti il progetto fissando una lastra di legno al soffitto, cui agganciò delle catenelle con contrappesi alle loro estremità, per comprenderne il portato e perché chiunque potesse vedere la Cattedrale ancor prima che fosse reale, guardando in su, come ogni volta che ci invade lo stupore.
Quella Cattedrale, immaginata vera ancor prima di esserlo e realizzata grazie a uno slancio visionario, è la nostra Agenda ONU 2030.
Ma se nell’Agenda è reso esplicito il diritto all’acqua pubblica, la fruizione all’arte è sempre più un fatto privato, elitistico e mediato, in mano a un sistema che la tiene lontana dalla strada, in balia del mercimonio, costringendola spesso alla clandestinità, come profetizzò Marcel Duchamp in una conferenza a Filadelfia del 1961: «Il grande artista di domani sarà underground». Sentimentalmente, come sentimentale è stata l’educazione di quel bambino che inciampava nell’arte e innocentemente, inconsciamente se ne imbeveva, in seno alla dicotomia pubblico/privato gli domando allora qual è il suo rapporto con le opere, una volta donate al pubblico. Che ne è di quelle spighe di grano assetate, di quei petali, di quella meteora naufragata, di quel viaggio sulla luna? «Quelle opere diventano parte di una mappa», mi risponde. «Di una mappa nuova. Che dà senso ai luoghi, ma soprattutto ai passaggi. Quando mi chiesero, ad esempio, di realizzare un’opera per la metropolitana di Scampia pensai a quegli anni. Pensai che ogni giorno tanti ragazzini avrebbero preso quei treni per andare a scuola e sarebbero passati davanti alla mia opera. Elegia nacque con questa consapevolezza. E io la costruii in modo che fosse il serbatoio di mille storie possibili. Una stanza vuota, con pochi elementi, i pezzi perfetti di una drammaturgia interiore che non aspettava altro che avere una sponda visiva per cominciare a sgorgare. Talvolta passeggio vicino a quell’opera e ascolto le persone che si scambiano idee su ciò che ci vedono. Per alcuni è lo studio di un San Girolamo contemporaneo, per altri è un carcere, per altri una povera casa. In ognuna di queste storie, il protagonista è colui che guarda. Ecco, dunque, che ne è di queste opere. Restano dispositivi a disposizione del pubblico. Quelle permanenti, poi, hanno una virtù particolare: sono luoghi in cui si può tornare. È così che mi dicono le persone. Non mi dicono mai: volevo rivederla. Dicono: volevo tornarci. Tornare in un luogo e trovarlo ancora lì è qualcosa che va anche al di là di una esperienza visiva. È la manifestazione di una casa dell’anima. Ecco, sono onorato e felice quando ho la possibilità di lasciare in giro delle case dell’anima, in cui alcuni possano tornare».
È una metafora che riscalda, quella dell’opera d’arte come casa dell’anima appena evocata da Tosatti, ma nella sua arte ce n’è una più ricorrente, che non riscalda ma brucia: quella dello specchio. Non è solo il titolo di uno dei suoi cicli più impegnativi, Il mio cuore è vuoto come uno specchio – che dal 2018 lo sta portando nel mondo a comporre un ritratto decadente di un’idea di democrazia globale alla deriva, di fronte alla quale è cogente e cocente rispecchiarsi per potere immaginare una nuova via di salvezza – ma è anche la metafora che Tosatti individua per se stesso in quanto artista: quella di costruttore di specchi. «L’artista ha il compito di piantare uno specchio nella realtà, tagliente, come un rasoio aperto nell’aria». L’anima sintetica dello specchio, sintetica perché racchiusa nella sola sintesi di una cornice, permette la concentrazione sui punti di crisi individuati dall’artista per fare definitivamente, e una volta di più, i conti con noi stessi. Ma la funzione dello specchio – che nell’arte deve necessariamente allontanarsi dalla descrizione pedestre, da un’idea inflazionata di ricerca della verità che lasciamo volentieri alla cronaca perché l’arte non è, con tutto il rispetto, il reportage – è quella di un vuoto a rendere: «Il costruttore di specchi non è quello che costruisce l’immagine che c’è nello specchio, e quello che c’è di importante nello specchio è l’immagine». E quel riflesso restituito dall’arte, l’immagine, passa attraverso «un processo di conoscenza e, successivamente, di condivisione di quella conoscenza, che richiede un superamento, una dialettica. Che non faccio solo io, facendomi invadere dalla cultura di un luogo, ma che la città stessa compie nel momento in cui restituisco, come un’onda di ritorno, quell’intero patrimonio di conoscenza messo in una precisa frequenza, in un ordine che è simile alla struttura atomica di una lama».
Una metafora è capace, come da suo etimo – metafora: derivato dal greco μεταφορά [-ᾶς, ἡ] 1. trasporto 2. cambiamento 3. trasferimento – di trasportare come il mare, di evocare un altrove, come l’immaginazione. Di creare potenti icone di fronte alle quali raccogliere e raccogliersi, riflettere e riflettersi.
Fondendo la mia metafora dell’arte come acqua alla sua dell’arte come specchio, ne ricavo uno specchio d’acqua, e penso che su uno specchio d’acqua vive un mito fondativo della cultura occidentale, quello di Narciso, innamoratosi fatalmente di sé guardando la sua immagine riflessa in uno specchio d’acqua. Leon Battista Alberti (De Pictura, 1435) è stato il primo a riconoscere metaforicamente in Narciso, che amò nient’altro che un’immagine, il padre dell’arte figurativa. Sull’onda dei secoli il tema dell’autoritratto è un loop della storia dell’arte. L’artista si fa tela bianca ed effettivamente specchio, della cui immagine innamorarsi e fare innamorare. Del resto, uno dei momenti spartiacque dell’attività dell’artista è quello che si chiama mostra: esibizione della propria opera e della propria visione, nuda.
Ho un pensiero: quello per cui l’artista è Narciso, chino sullo specchio d’acqua di un’urgenza da condividere, e non un narciso qualsiasi, devoto a un black mirror a cristalli liquidi capace di rifletterne solo la vacuità. Tuttavia, un sistema della cultura contemporaneo annacquato dal politically correct non sa guardare al di là della superficie, non sa leggere Oscar Wilde, Jean Genet, Pier Paolo Pasolini, Carmelo Bene, non sa vedere che «Una spada riflessa nell’acqua prende figura di croce» (Giovanni Papini, Il diavolo, 1953), non mancando di mettere Narciso in croce tutte le volte che gli è data occasione.
Gli domando allora – nel processo costantemente inferto a Narciso, e al Narciso-Tosatti in quanto artista – a quali parole affiderebbe la sua arringa difensiva, ma Gian Maria si dichiara innocente per non aver commesso il fatto, «perché il mio riferimento non è Narciso, ma Dorian Gray. Il ritratto è l’unico specchio capace di mostrare l’anima. E per questo il ritratto è l’unica arma che può uccidere il mostro che è dentro di noi. Io costruisco specchi che ci possano mostrare il nostro vero volto e ci facciano venire voglia di cambiare, di uccidere ciò che di noi ci risulta insopportabile. L’arte, in fondo, serve a questo: non a pacificarci, ma a incendiarci».
Torno allora un tantino caparbia su Narciso, ma solo per allargare il piano dando voce alla coprotagonista del mito, l’acqua, e recupero il riferimento di Tosatti a Oscar Wilde perché, nel suo racconto Il discepolo (1894), non è solo Narciso a rispecchiarsi nell’acqua per godere della propria bellezza, ma è anche l’acqua a farlo, contemplandosi nello specchio dei suoi occhi, essa stessa divenendo Narciso. E al di là dell’appagamento da ambo le parti, «L’acqua ci ha inventato per farsi ammirare», scrive Alok Jha nel Libro dell’acqua (2016).
Come dire, la bellezza va condivisa. E sono in questo totalmente d’accordo con Gian Maria: non il decoro grazioso e lobotomizzato, ma quella bellezza che fa proprio anche l’unheimliche, il perturbante, non per pacificarci, ma per incendiarci.
Quella bellezza che fai fatica a sostenere.
L’insostenibile sostenibilità dell’arte.
È il momento di parlare con Gian Maria Tosatti di sostenibilità.
Colonna portante di quella Cattedrale che è l’Agenda ONU 2030, in un mondo che abbiamo pericolosamente traghettato sull’orlo della deriva, è la ricerca della sostenibilità, unica risposta alla complessità del nostro tempo, sistematizzata da Edgar Morin nella sua transdisciplinare e fluida Teoria della Complessità.
Cadono le certezze, ed è questa l’unica certezza che deve portarci a danzare, come stelle generate dal caos. Come l’acqua, che trova sempre una strada per fluire. Nella Teoria della Complessità è la cultura il tratto attraverso cui l’essere umano emerge dalla natura, sua madre, mediante un movimento che è stato disgiunzione, ma che deve necessariamente switchare in (ri)congiunzione. L’essere umano alla natura, attraverso la cultura: nell’ottica di Morin l’apporto della cultura, e dunque dell’arte, deve portare i tratti di questo urgente cambio di paradigma. Nel 2016, il saggio Systems in art making and art theory: complex networks from the ashes of Postmodernism di Philip Galanter, padre dell’arte generativa, si è occupato della definizione di un’opera d’arte complessa: un’opera che accresce la consapevolezza dello spettatore, parte attiva dell’opera, rispetto al mare di cui non siamo che un sorso. Non più un’immagine, ma un ambiente. Non più una goccia, ma un torrente. Non più un albero bensì una foresta, con le sue vitali interazioni, che prospera sulla biodiversità. Opera viva. Nel sentirmi profondamente affratellata a Gian Maria Tosatti nella guerra a etichette marcescenti, sbarazzo allora dal campo critico di queste pagine l’idea che sostenibilità nell’arte equivalga a political correctness, e accolgo la definizione che Galanter dà di arte complessa o sostenibile nel senso una sottolineatura, in parole, di ciò che l’arte fa per sua stessa natura: portare in luce un’urgenza, presente o prossima, attraverso una visione, quand’anche sia feroce – ed è fuor di dubbio che la Cattedrale dell’Agenda ONU 2030 sia un florilegio di urgenze, se chiediamo salvezza.
Sulla traccia della metafora di questo cammino, se l’arte è acqua, il gesto artistico è rabdomanzia. «L’artista ha un ruolo – che sia morale o immorale, questo è un altro discorso. Un po’ come i profeti della tragedia e dell’epica: a volte sono amati, a volte combattuti, altre incatenati, altre ancora riescono a salvare il destino di qualcuno. L’artista è sempre un Tiresia, qualcuno che conosce non perché sia un dotto, ma perché riesce a leggere nelle vibrazioni della natura. L’arte è capace di dirci le cose un attimo prima che accadano», Tosatti ha scritto.
«Nei sistemi complessi, l’imprevedibilità e il paradosso sono sempre presenti», Morin ha scritto, in Introduzione al pensiero complesso (1993). Dell’imprevedibilità – o meglio, di una forma di previsione non coscrivibile al metodo scientifico, ma a una più potente sensibilità – abbiamo dunque detto disegnando l’artista come Tiresia, o come un rabdomante. Vengo al paradosso: ricordo una puntata di La fabbrica del mondo, programma in onda in prima serata su Rai 3 nei primi mesi del 2022, condotto dal drammaturgo Marco Paolini e dal filosofo della biologia Telmo Pievani, dedicata proprio al diritto universale all’acqua. Ricordo il monologo di Paolini. In Italia si consumano sei milioni di metri cubi di acqua al minuto, di cui oltre il 40% si disperde a causa di una rete idrica di cinquecentomila kilometri maltenuta, «ma questo non ci colpisce, perché manca un’emozione». Giunture, guarnizioni, fori, prelievi abusivi; ma senza un’emozione, difficilmente un consiglio di amministrazione farà della manutenzione idrica una priorità. Eppure l’acqua, ormai lo sappiamo, è risorsa preziosa e non infinita. Esiste il concreto pericolo che gli appelli degli scienziati sul riscaldamento globale o sulla acidificazione degli oceani, e i Fridays for Future di una Generazione Z che mostra di avere una capacità di visione e un senso di responsabilità infinitamente maggiore dei poltronisti ammuffiti nelle stanze dei bottoni, restino rumore bianco finché il passato collettivo, i miti, l’immaginazione, e il gesto artistico, non sapranno tradurli in un’immagine potente, non sapranno immergere dati grezzi nel patrimonio culturale, per vestirli e investirli di un’emozione.
Penso allora, seguendo la traccia di un recente articolo di Ludovico Pratesi sul rapporto tra arte contemporanea, Teoria della Complessità e sostenibilità, a Imitatio Christi di Roberto Cuoghi, una delle opere con cui il Padiglione Italia si è presentato alla Biennale Arte di Venezia nel 2017: una fabbrica di calchi di Cristo in croce, un cristificio in via di decomposizione in cui ti investiva il tanfo dell’umidità, in cui, come ha rilevato Pratesi: «L’artista si affida alla forza generativa del caso e del disordine della decomposizione, in grado di generare raffigurazioni iconiche che mutano nel tempo in maniera imprevedibile, creando un campo iconografico dinamico ed emergente in cui lo spettatore è immerso».
E penso a Gian Maria Tosatti, alla sua storia in arte che fa leva sull’esperienza del visitatore come enzima dell’opera – piena esperienza estetica, laddove “estetica” asseconda il suo etimo di aísthesis, percezione – e penso in particolare alla sua Storia della Notte e Destino delle Comete al Padiglione Italia. Il corredo comunicativo, in quest’occasione presente, ci parla di un forum continuo per approfondire la ricerca su modelli di vita e sviluppo sostenibili, le cui riflessioni sono consultabili su www.notteecomete.it/public-program; di un’opera coerente all’impegno di sostenibilità della Biennale di Venezia, che raccoglie i dati relativi alle sue emissioni compensandole economicamente, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 la completa neutralità carbonica; di un esplicito riferimento all’Agenda ONU, toccando in arte tutti i temi dei diciassette obiettivi di sostenibilità tra cui non soltanto il diritto universale all’acqua – protagonista che allaga la grande piazza di carico nell’atto finale dell’opera, permettendo agli spettatori e alla stessa Venezia, città sommersa, ancora una volta di specchiarsi – ma anche quelli legati alla tutela della natura, allo sviluppo sostenibile rispetto al territorio, al ripensamento dei modelli etici di produzione, di consumo, di profitto.
E al di là della comunicazione, soprattutto, c’è l’arte. Storia della Notte e Destino delle Comete è l’immersione totale in uno spazio di duemila metri quadri da percorrere in solitudine, da cui emergere emotivamente carichi. È un lavoro dalla sintassi teatrale, evocativo della struttura e della funzione della tragedia greca, il cui primo atto è dedicato all’ascesa e al declino del sogno industriale italiano – di oro e di ruggine i suoi sapienti interventi pittorici, oro come incorruttibilità e ruggine come erosiva corruzione – laddove il secondo atto, acqua increspata, oscurità e il flebile, ma ancora percepibile, brillare delle lucciole, è la deflagrazione dell’elemento catartico, purificazione dopo un cammino impervio, segno di una pace ancora possibile che riscatta il monito del 1975 di Pasolini: «Darei l’intera Montedison per una lucciola». Rieccole, le lucciole; tuttavia, occorre averne cura.
In una recente intervista per Flash Art, è stato chiesto a Tosatti in cosa consistesse, nell’arte, la dimensione della speranza. Riporto testualmente le sue parole: «Per me sono le lacrime, quelle che ho raccolto dai visitatori di questo Padiglione. Da queste testimonianze ti accorgi che la partita non è finita, che siamo ancora capaci di emozionarci, perché queste cose ci fanno bruciare il sangue nelle vene. Penso che per sperare sia sufficiente constatare tutto questo, la nostra capacità di essere ancora vivi, di vibrare, di tremare ancora». Le lacrime, 98.2% di acqua. L’emozione necessaria di cui parlava Paolini per sensibilizzare sul diritto universale all’acqua e, più in generale, sulle urgenze poste in essere dall’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Eccola, la funzione dell’arte in supporto ai diritti. Ed eccolo, a mio avviso, il paradosso sempre presente nella complessità dei nostri tempi, applicato all’arte e alla sostenibilità: al di là della forma, perché l’arte sia sostenibile occorre che essa sia emotivamente insostenibile. Che scuota dall’interno, come un crocifisso corrotto dalla muffa, come Salò o le 120 giornate di Sodoma. È stata per me insostenibile, dunque vivifica, la cura di Gian Maria Tosatti nel riempire di foglia d’oro ciascun singolo foro di proiettile in una parete crivellata di colpi, nel sesto episodio delle Sette Stagioni dello Spirito. È stato per me insostenibile, dunque vivifico, guardare il disegno del suo progetto di costruzione di un arcobaleno alto venti metri e largo cinquanta a Calais – arcobaleno, fisicamente acqua e luce, meta/fisicamente eterno simbolo di una nuova alleanza – e pensare a quello che di bello sarebbe potuto accadere, se solo si fosse data priorità all’umanità.
E quando gli chiedo il nome di tre opere che anche per lui siano state emotivamente insostenibili ( = f inalmente sostenibili), Gian Maria travolge ogni argine: «Tre… no, non è possibile dirne solo tre. Non più tardi di qualche settimana fa, io e Lucrezia Longobardi siamo rimasti per un tempo incalcolabile imbambolati a guardare un dipinto che conosciamo benissimo: La Chambre de Van Gogh à Arles. E lo stesso posso dire di tante altre. Il monologo del coniglio sul finale del primo atto dell’Orestea della Socìetas Raffaello Sanzio, l’Otello di Eimuntas Nekrošius, il dialogo muto tra i due protagonisti dell’Ivanov di Čechov inventato di sana pianta da Tamás Ascher, ogni singola Madonna di Vincenzo Bellini, La Traviata di Verdi con Anna Netrebko e Rolando Villazón, Fuga per la vittoria di John Huston, lo sguardo che Charlie Chaplin lancia ai monelli che lo scherniscono subito prima dell’ultima scena di Luci della città. Eduardo De Filippo quando sta in scena e sembra che ci stia dai tempi di Eschilo. Le periferie di Sironi o il Natale al Pio Albergo Trivulzio di Angelo Morbelli, Elisa di Arcangelo Sassolino, un’opera di Mondrian che sta al Philadelphia Museum of Art e poi La morte della Vergine di Caravaggio, De Chirico fino a tutti gli anni ’20, la Seconda Sinfonia di Mahler messa in scena da Romeo Castellucci ad Aix-en-Provence nel 2022 mentre nei boschi dell’Ucraina si disseppellivano i cadaveri della guerra, Captain America che si stringe al braccio lo scudo in frantumi alla fine di Avengers: Endgame, il Ratto di Proserpina di Bernini, le litografie di Odilon Redon, i protagonisti de L’uomo senza qualità di Musil che suonano il pianoforte insieme perché non sanno più parlarsi, la danza finale di Pippo Delbono in Questo buio feroce, la lettera di Dostoevskij scritta poche ore prima della sua esecuzione fortunatamente sospesa, la Napoli di Anna Maria Ortese, il cinema di Pasolini e Tarkovskij, quello di Totò e Fabrizi, quello di De Sica… Sono troppe, troppe cose, troppa bellezza», mi dice, e io mi rendo ancora una volta conto di quanto un artista, al di là della fama, al di là dei riconoscimenti, sia per sempre benedetto e condannato alla costante sete di arte. «Si dovrebbe poter vivere cento volte solo per poter mantenere tra le dita tutto questo, avendo il tempo necessario per goderne. E io spero che i miei uccelli colorati che volano nella cattedrale bianca inerpicata in cima a un’alta scalinata napoletana, il mio appartamento di Cape Town disseminato di bicchieri d’acqua mezzi vuoti e di denti umani, la mia notte fonda in cui, su un mare buio, vola uno sciame di lucciole, possano essere nella lista infinita di qualcuno – o, almeno, delle persone che hanno avuto la ventura di realizzare quelle opere assieme a me».
Quei compagni di viaggio a cui Gian Maria Tosatti, capitano di ventura della sua personalissima s toria (come in quella meravigliosa canzone di Gabriella Ferri, a proposito di lacerante bellezza: ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente…), non ha mai mancato di porgere il proprio omaggio e la propria gratitudine; il che è tutto fuorché scontato, in tempi che via via si sono fatti sempre più complessi, sempre più scomposti e atomizzati, sempre più liquidi.
«Abbandonate ogni speranza di totalità, futura come passata, voi che entrate nel mondo della modernità liquida», scrisse il profeta Zygmunt Bauman più di venti anni fa battezzando, per il tempo all’interno del quale navighiamo a vista, la caratteristica più pertinente: quella della liquidità. E per capire immediatamente il paradigma della modernità liquida, per me non c’è niente di meglio che accostare Zygmunt Bauman all’hip hop.
New York, Bronx, anni Ottanta. La controcultura hip hop emerge per denunciare, attraverso un cluster di stile pressoché completo, l’invisibilità a cui la (ri)segregazione aveva relegato migliaia di giovani afroamericani, cresciuti in aree suburbane abbandonate a loro stesse. L’asse intorno a cui ruota è, in una parola, il flow – in italiano il flusso, ma rende decisamente meno –, capacità dell’hip-hopper di creare una continuità liquida a partire da una serie di frammenti: il dj, mixando i break e inserendovi come in un unicum i più eterogenei campionamenti; il writer, incastrando le lettere della tag l’una dentro l’altra; il breakdancer, scivolando in una dinamica di gesti sincopati che poi scorrono splendidamente fluidi; il rapper, applicando schemi metrici e tonali in una cadenza che decostruisce il linguaggio e le relazioni di potere incrostate al suo interno, divenendo il suo inequivocabile stilema.
Il suo flow.
In Spectacular Vernaculars: Hip Hop and the Politics of Postmodernism (1995), Russell A. Potter scrive: «La triade hip hop formata da graffiti, ballo e rap è composta da arti post-apocalittiche per definizione, graffi sulle pareti decadenti dell’America urbana post-industriale. Se ci sono momenti analoghi nelle cronologie dell’arte europea sono da ricercare nella demenza carceraria della Roma di Piranesi, o nelle giustapposizioni situazioniste della Parigi di Debord. Il tempo dell’hip hop è post apocalittico e il suo proscenio è la Società dello Spettacolo, in cui la forma di mercificazione definitiva è quella dell’immagine spettacolarizzata. L’hip hop ambisce a un mondo scomposto, che fratturi il frammentato, graffito su graffito». Ed eccolo, in nome di quella modernità liquida che connota il contemporaneo, l’abbandono della totalità che fu propria del Fluxus a favore della più nebulizzata liquidità del flow, del flusso.
Flusso come movimento, e come flussi migratori: non a caso, il nostro è stato definito il secolo dell’esilio. Da Napòlide – mi sembra perfetta anche per Gian Maria Tosatti la definizione che coniò per sé Erri De Luca – quello delle migrazioni è un flusso che l’ha visto più volte immerso, da artista e da uomo, da The Kingdoms of Hunger (2013), denti sparsi come fossili contemporanei in una Mole Vanvitelliana come Mare Nostrum, a Histoire et Destin nella Jungle di Calais, sulla cui spiaggia l’ideale di una nuova alleanza è naufragato.
Flusso come linguaggio, schema di potere all’interno del quale l’umanità intera si immerge, da «L’acqua è il principio di tutte le cose» (Talete di Mileto, VII-VI sec. a.C.) a «In principio era il Verbo» (Giovanni 1,1). Il mio cuore è vuoto come uno specchio è la traduzione in italiano del titolo ufficiale del suo progetto, לגיפּש ַא יוו קידייל זיא ץרַאה ן ַ יימ, che è in Yiddish. Il motivo di questa scelta deriva dalla constatazione dell’importanza del linguaggio nello strutturare una società, e l’Yiddish, sostenne nel 1978 il Nobel per la letteratura Isaac B. Singer, è la lingua delle anime nude, «una lingua di esilio, senza una terra, senza frontiere, non sostenuta da nessun governo; una lingua che quasi non possiede parole per armi, munizioni, esercitazioni e tattiche militari; l’idioma saggio e umile di tutti noi, la parlata della spaventata e speranzosa umanità». Di contro, il filologo Victor Klemperer in LTI, la lingua del Terzo Reich: taccuino di un filologo (1947) rilevò come «Il nazismo si insinuava nella carne e nel sangue della folla attraverso le singole parole, le locuzioni, la forma delle frasi ripetute milioni di volte, imposte a forza alla masse e da questa accettate meccanicamente e inconsciamente». Perché se alcune parole fluiscono come l’acqua, altre lo fanno come l’arsenico.
Flusso come tempo, che corre e ricorre, come la storia per Vico, come le onde nel mare. Eppure c’è un tempo, quello dell’arte, che deve necessariamente operare sulla scala dell’eternità, perché l’arte non potrà mai essere un’istantanea da trend topic. In questo senso Caravaggio è assolutamente contemporaneo. In questo senso le installazioni di Gian Maria Tosatti sono fuori dal tempo, cristallizzate e cristalline come il grado zero dell’acqua, post-apocalittiche e purgatoriali come la Zona di Stalker (Andrej Tarkovskij, 1979). Come l’Episodio di Odessa di Il mio cuore è vuoto come uno specchio (2020), otto lampioni accesi e abbeverati dall’energia nucleare della vicina Chernobyl su un lago, quello di Kuyalnik, la cui acqua è senza soluzione di continuità con il cielo. «Sono anni che faccio opere sul futuro e le persone ci vedono dentro il passato. È fantastico. Questo la dice lunga sui legami che intercorrono tra futuro e passato. Io credo che nel nostro modo di guardare al tempo ci sia un errore di fondo. Ci relazioniamo ai concetti di passato, presente e futuro con i parametri di creature dalla prospettiva estremamente ridotta. Una vita per noi è una misura imponente. Ma nel tempo assoluto è nulla», ha dichiarato Tosatti in una recente intervista. Arte immersa in un tempo assoluto, come assoluto è il tempo dell’acqua.
Flusso come corrente. Se il tempo dell’arte deve essere assoluto, è in correnti che si scandisce il tempo della sua storia; e se Tosatti come artista è chiamato a operare sulla scala dell’eternità, Tosatti come intellettuale analizza il presente e il passato anche per poter leggere il futuro. Tuttavia, nella modernità liquida, anche l’arte risente del suo tratto connotante di frammentazione, di atomizzazione, di individualismo spinto, al punto che in Italia le ultime correnti storicizzate dell’arte contemporanea si arrestano alla seconda metà del secolo scorso: la corrente dell’Arte Povera di Germano Celant negli anni Sessanta, e quella della Transavanguardia di Achille Bonito Oliva nel decennio immediatamente successivo.
Poi il silenzio; o meglio, una generazione di artisti notevoli, ma soli. Eppure l’acqua è fatta di gocce, che probabilmente non si unirebbero tra loro – e nelle loro stesse interazioni molecolari – senza la direzione di quella che suggestivamente chiamiamo memoria dell’acqua, che è il suo campo elettromagnetico. Questo mi fa pensare, sulla traccia della metafora tra arte e acqua, che quello che manca non è l’arte, ma una direzione che la faccia confluire in corrente. Almeno fino ad ora, perché la statura di un intellettuale – che non certo per investitura divina è stato scelto come direttore artistico della Quadriennale – passa anche, e soprattutto, per la sua capacità di saper leggere il contesto. Gli domando allora, come domanderei ad ABO della Transavanguardia, quali sono i tratti critici e gli artisti che confluiscono nella corrente, da lui individuata, del Neorealismo Visivo: «Credo di poter dire che Lucrezia Longobardi, in un bel libro recente intitolato 15 ipotesi per una storia dell’arte contemporanea, si spinga molto più a fondo di quanto abbia fatto io nel teorizzare la rete di legami che tiene assieme quella generazione di artisti per la quale inventai quella denominazione. E c’è un passaggio di quel libro che, talvolta, mi torna alla mente e, se me lo consente, lo cito letteralmente: “È questo, forse, il primato che va riconosciuto all’arte italiana degli anni Dieci sulle neo-avanguardie e post-avanguardie del secondo Novecento. La sua sussistenza in ragione non di una lettura critica di impostazione, ma di una reale convergenza poetica. L’arte degli anni Dieci in Italia esiste in forza di una coerenza riscontrabile nella pratica e non nelle intenzioni. Esiste in forza di una coerenza che non ha avuto bisogno di guardiani e teorizzatori. L’arte degli anni Dieci è un’arte orfana, cresciuta per strada, senza padri o educatori. È un’arte figlia di nessuno, e quindi, fino ad oggi, da nessuno riconosciuta nell’insieme del suo fenomeno. È questa, probabilmente, la ragione del silenzio critico che l’ha avvolta (al di là delle già citate mille monografie, talvolta commissionate e pagate dai diretti interessati). Ma, per questo, è un’arte più forte, più robusta e, forse, più capace di lasciare tracce profonde, che possano incidere anche nei decenni successivi”». «Per questo – controbatte Tosatti in maniera gentile, ma ferma – contesto l’idea che serva una regia. È un bluff l’idea che l’arte si possa dirigere. Anche Celant è un mito ben più grande dell’uomo che c’era dietro. Credo, invece, che serva una generazione critica forte tanto quanto quella artistica, per trovare il giusto bilanciamento in cui tutto prolifera. Ai tempi dell’Arte Povera – e delle tantissime altre cose che in quel momento accadevano – c’era questo equilibrio. È questo il segreto».
È come se, nella modernità liquida, quello di essere cani sciolti, flussi in una corrente, fosse un preciso stilema ascrivibile ai singoli artisti che la popolano, e che essi – presa coscienza del loro essere figli di nessuno – possano sentirsi anche più liberi di esplorare, con un certo senso di lucente spleen, la loro condizione di identità fluttuanti. «Se il tema moderno dell’identità riguardava come costruirla e mantenerla solida e stabile, il tema postmoderno dell’identità riguarda primariamente come evitare la solidificazione e lasciare aperte le opzioni», scrisse ancora Zygmunt Bauman, secondo il quale essere postmoderni equivale anche a essere in divenire, e nella modernità liquida «L’unica costante è il cambiamento, e l’unica certezza l’incertezza». Ciò significa che la ricerca dell’identità nel postmoderno non solo è immaginabile, ma è anche auspicabile, che una sua fissità è semplicemente limitante e che, dato un futuro incerto, è più che mai necessaria una grande capacità plastica.
Esattamente come accade per l’acqua. I passaggi di stato dell’acqua le permettono il mutamento da solido, a liquido, a gassoso, ed è la mutazione anche il tema portante della mostra principale della appena conclusasi Biennale Arte di Venezia, o della tematizzazione filosofica di Paul B. Preciado. «L’arte è transgender per definizione», Tosatti intravide e scrisse in un editoriale risalente a quasi quindici anni fa.
Tra biologico e bionico, tra identità e fluidità, tra organico e sintetico, carnale e acquatico, aprendo gli scenari anche alla ultra-realtà liquida, anfibia, del metaverso. «Molto del metaverso dipende da cosa siamo capaci di fare nella realtà che viviamo fisicamente. Se non costruiamo dei buoni cittadini nella realtà fisica, avremo dei barbari anche nel metaverso. Sono dimensioni diverse in cui agiscono le medesime responsabilità. Lo vediamo anche nei social, un metaverso light pieno di odio, più di quanto non ve ne sia nella realtà. Bisogna fare in modo che i luoghi in cui siamo siano dei luoghi non sicuri, ma sostenibili. Il metaverso ha molte risorse per tutto ciò che attiene ai temi legati all’identità. Nella realtà si può intervenire su un piano sessuale, ma se qualcuno si sente un delfino, non ci sono soluzioni possibili? Nel metaverso puoi essere un delfino. La proiezione nella realtà digitale aiuta ulteriormente a superare i limiti fisici. L’arte può avere un ruolo in questo scenario trans dimensionale», ha dichiarato Tosatti di recente. Gli chiedo allora quale forma sceglierebbe come sua, nel regno liquido del metaverso: «Io nel metaverso ci sono da vent’anni», mi dice. «È questo che sono tutte le opere che ho disseminato per il mondo. E la mia forma è quella invisibile dell’architetto».
La personalissima forma che darei io a Gian Maria Tosatti, nel microcosmo fluido del metaverso, asseconda in parte la sua risposta: Tosatti è per me quel Lucifero che lui stesso ha reso protagonista del terzo episodio delle sue Sette Stagioni dello Spirito, agli ex magazzini generali del porto di Napoli. Un Lucifero del tutto simile al mito greco di Prometeo, talmente innamorato dell’umanità da aver osato ribellarsi a Dio. Un Lucifero da sequel rispetto alla narrazione sacra, calato in un ambiente domestico dove al primo piano l’acqua bolle in pentola e i muri lacrimano, messo in punizione per l’eternità in una camera dorata con un aerosol, un libro di Jules Verne e un taccuino dove scrivere e riscrivere il proprio errore. Un Lucifero resosi consapevole dei propri sbagli, compiuti credendo di fare del bene, che Tosatti ha tratteggiato con indulgenza e una certa forma di tenerezza, perché il male assoluto non è per lui nell’errore, ma nell’inerzia. «Non: sono un uomo caduto, ma: sono uomo, e sto cadendo», scrisse Harold Bloom riferendosi proprio a Lucifero in L’angoscia dell’influenza (1973). Mi torna in mente la frase con cui si apre e si chiude L’odio (1995) di Mathieu Kassowitz: «Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. A mano a mano che cadendo passa da un piano all’altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: “Fino a qui tutto bene”. “Fino a qui tutto bene”. “Fino a qui tutto bene”. Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio». La caduta, l’errore, non hanno il carattere della definitività se abbiamo la forza di prenderne consapevolezza, e consapevolmente porvi rimedio. Lo stesso creare arte non è mai un atto innocente, né vincente. Occorre sbagliare per crescere, occorre saper vedere l’oro in un fallimento – come ammonì Pasolini o, tornando all’acqua, come fece Erasmo negli Adagia (1508): «Quando ho fatto naufragio, allora ho ben navigato».
Abbiamo creduto che l’uomo fosse onnipotente. Abbiamo sbagliato. Possiamo ancora porvi rimedio. Abbiamo creduto che l’acqua fosse illimitata e il suo scorrere immutabile, e invece l’accelerazione del suo ciclo, impazzito per i nostri deliri, è causa dei fenomeni estremi che ci stanno piagando e s tanno piagando il pianeta. Abbiamo sbagliato. Possiamo ancora porvi rimedio. «Ogni cosa ha dei limiti», mi dice Gian Maria. «Oggi, per la strada, ascoltavo una vecchia canzone di Capossela. Avrei voluto chiamarlo per dirgli che ha ragione. Noi artisti siamo generali di eserciti di soldatini di piombo. E poco importa che siano animati. Sono pur sempre figurine. Ma hanno presa sull’immaginazione. E così, per quella parte di noi che resta ancora innocente, quelle nostre battaglie fatte con un po’ di colore e due tratti accennati possono produrre ferite nella corazza, ferite da cui è possibile estrarre di nuovo il nostro cuore per esporlo a tutti i venti, per farlo tornare a respirare. Perché la vita ci sfugge. Ma l’arte ci viene a cercare».